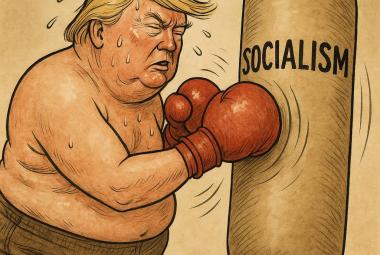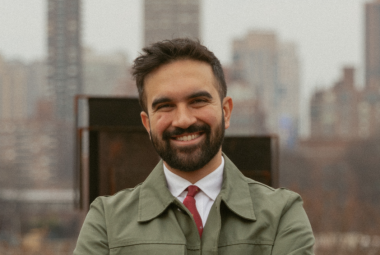Negli ultimi anni, il dibattito pubblico ha visto il passaggio dalla "post-verità" alla "anti-verità", - scrive Massimo Cacciari su La Stampa - un fenomeno in cui la politica non solo ignora i fatti ma li distorce attivamente per fini propagandistici. La verità, pur essendo un concetto complesso, ha sempre implicato una relazione con la realtà. Tuttavia, quando il linguaggio politico si trasforma in uno strumento di manipolazione, la realtà viene sostituita da narrazioni finalizzate a influenzare l'opinione pubblica.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incarna perfettamente questa dinamica. Le sue dichiarazioni su Volodymyr Zelensky, definendolo un dittatore, dimostrano una mescolanza di ignoranza e intenzione propagandistica per giustificare un possibile cambiamento di rotta politica. In realtà, Zelensky è stato costantemente condizionato dagli elementi più estremi del nazionalismo ucraino, rendendo l'accusa di dittatura priva di fondamento.
Ancora più grave è stata la sua affermazione sulle deportazioni di massa dei palestinesi e sul possibile sfruttamento economico delle spiagge di Gaza, una proposta che rasenta l'indecenza. Ciò che preoccupa è la mancata reazione adeguata dei leader europei, che avrebbero dovuto esprimere un fermo ripudio di queste parole.
L'uso della propaganda non è limitato a Trump. Anche il modo in cui si sono tracciati paralleli storici tra la Russia di Putin e il Terzo Reich è un esempio di strumentalizzazione della memoria storica per scopi politici. La Russia di oggi, a differenza dell'epoca sovietica o zarista, non ha la capacità di lanciare un'offensiva globale contro l'Occidente. La sua stessa stabilità interna è fragile, e il riconoscimento delle sue esigenze di sicurezza deve andare di pari passo con il pieno riconoscimento della sovranità degli Stati post-sovietici. Questa sarebbe la base di un trattato di pace storico che non è mai stato realizzato dopo la caduta del Muro di Berlino.
La storia insegna che i veri trattati di pace nascono quando la propaganda si placa e viene riconosciuta la realtà dei rapporti di forza. Dopo centinaia di migliaia di morti in Ucraina, è giunto il momento di un accordo che ponga fine al conflitto. Senza evocare paragoni storici impropri, l'equilibrio globale attuale è più complesso rispetto al passato, con la necessità di considerare la molteplicità di potenze e interessi in gioco. Se l'Occidente perseguirà una strategia egemonica globale, il rischio di una nuova guerra mondiale sarà inevitabile.
La realtà geopolitica richiede un ritorno ai principi degli accordi di Minsk, che già prima dell'invasione russa erano stati sostenuti da molti leader europei. Continuare il conflitto, senza cercare una soluzione negoziale, non solo aumenterà le sofferenze del popolo ucraino, ma rafforzerà il regime di Putin. Le questioni territoriali, come la Crimea e il Donbass, devono essere affrontate con soluzioni pragmatiche: la Crimea è de facto parte della Russia, mentre per il Donbass l'opzione più realistica è uno statuto di autonomia all'interno dell'Ucraina, garantito da un referendum sotto supervisione internazionale.
L'Europa ha un ruolo chiave in questo scenario. Dovrebbe finalmente prendere parola con una posizione autonoma e realistica, proponendo soluzioni concrete invece di seguire passivamente strategie dettate da altri. Potrebbe anche dispiegare una forza di interposizione per garantire la pace nelle zone di guerra. Tuttavia, la domanda resta aperta: saprà l'Europa imporsi come un attore politico dotato di una propria visione o continuerà a essere una realtà marginale, subordinata agli interessi di Washington? L'Unione Europea sembra trovarsi di fronte all'ultima possibilità di affermare il proprio peso politico prima di cadere definitivamente nell'irrilevanza.
Immagine: dai social della Casa Bianca. Trump pubblicizza l'istituzione dell' "Ufficio della Fede". L'immagine richiama l'affresco di Leonardo da Vinci, "L'ultima cena".