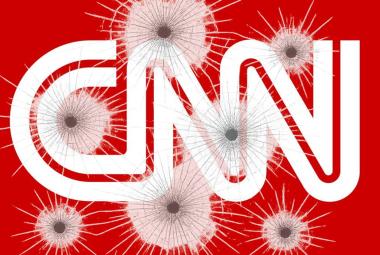L’articolo - un dialogo tra il giornalista Domenico Quirico e l’analista Gabriele Segre pubblicato su La Stampa - propone una riflessione profonda sul significato della parola "pace", oggi tornata di attualità a causa del ritorno della guerra in Europa. La pace, si osserva, è una parola usurata, utilizzata retoricamente senza più un vero contenuto condiviso. È associata a un'epoca di prosperità che l’Occidente credeva definitiva, ma che la realtà ha contraddetto brutalmente.
Domenico Quirico denuncia come l’Europa abbia imposto una visione ideologica della pace, costruita su illusioni e dogmi, senza una reale comprensione delle dinamiche del conflitto. Si è dato per scontato che la pace fosse uno stato permanente e garantito, sostenuto da regole internazionali e valori condivisi. Tuttavia, ciò che si è realizzato è stato un fragile equilibrio di poteri, più che una pace autentica. Quirico sottolinea che l’Occidente ha smesso di interrogarsi sulla natura e sul prezzo della pace, finendo per confondere la fine della guerra con la vittoria della ragione.
Segre concorda sull’inadeguatezza del concetto occidentale di pace, osservando come esso sia spesso declinato in forma astratta e moralistica, mentre nella realtà è spesso un compromesso tra interessi contrapposti. La pace, secondo lui, non si fonda su valori universali, ma su equilibri precari costruiti in contesti specifici. In questa visione, anche gli accordi più stabili non garantiscono una pace duratura, se non sono supportati da relazioni concrete, da una cultura del dialogo e dalla volontà di affrontare i conflitti in modo costruttivo.
Entrambi gli autori criticano duramente l’approccio delle classi dirigenti europee, incapaci di prevenire il ritorno della guerra e troppo spesso prigioniere di narrazioni consolatorie. In particolare, si accusa l’Occidente di aver ridotto la pace a una parola vuota, incapace di spiegare o gestire il ritorno della violenza armata. Il fallimento è stato duplice: sia nella comprensione delle dinamiche geopolitiche, sia nella capacità di intervenire efficacemente nei conflitti emergenti.
Quirico osserva che oggi la guerra è tornata a essere una componente costante della realtà, e che parlare di pace senza tener conto di questo fatto significa continuare a illudersi. Il vero errore, a suo parere, è stato pensare che il conflitto fosse definitivamente superato in Europa, dimenticando che la pace, per essere reale, deve essere continuamente costruita e difesa. Non basta proclamarsi pacifisti: occorre assumersi la responsabilità politica di creare le condizioni per la pace, anche attraverso il riconoscimento del fallimento e l’accettazione della complessità del mondo.
Segre aggiunge che la retorica della pace ha spesso impedito di leggere con lucidità i segnali di crisi. Quando un aggredito si difende con le armi, viene celebrato come eroe; ma quando un Paese europeo cerca di prevenire il conflitto con la diplomazia, viene accusato di debolezza. Questo paradosso dimostra quanto sia difficile mantenere una posizione coerente in un mondo in cui i valori sembrano essere costantemente manipolati a fini politici.
Il dialogo tra Domenico Quirico e Gabriele Segre invita a ripensare radicalmente il significato di pace: non più come slogan ideologico, ma come progetto politico concreto, radicato nella realtà e consapevole della fragilità dell’equilibrio internazionale. Serve una nuova cultura della pace, capace di riconoscere il fallimento delle illusioni occidentali e di affrontare la guerra non solo come tragedia da evitare, ma come realtà da comprendere per trasformarla.
Foto: dipinto di Sofia von Humboldt