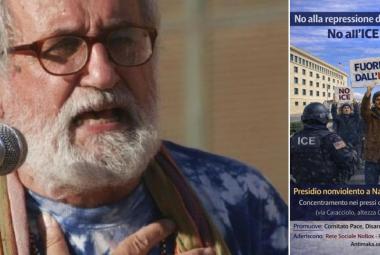Il 9 ottobre 2023, il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant annunciò che non avrebbe permesso l’arrivo a Gaza di elettricità, cibo o carburante, giustificando la decisione come una lotta contro “bestie umane”. Dichiarazioni come quella di Tally Gotliv, membro della Knesset, che suggerì di sfruttare la fame per ottenere informazioni, sottolineano l’intenzionalità politica dietro questa strategia. Nei mesi successivi, Israele non solo ha ostacolato l’arrivo degli aiuti, ma ha distrutto infrastrutture per la produzione e la distribuzione alimentare (campi coltivati, panetterie, mulini, negozi), spingendo i residenti a condizioni di sopravvivenza estrema.
Lo afferma su Al-Jazeera la psichiatra Samah Jabr, psichiatra e responsabile dell’Unità di salute mentale presso il Ministero della Salute palestinese e professoressa associata di Psichiatria e Scienze Comportamentali presso la George Washington University. L’impatto psicologico e sociale di questa politica va ben oltre Gaza, sostiene la dottoressa Jabr, colpendo anche Gerusalemme Est e la Cisgiordania. La sofferenza della popolazione di Gaza si inserisce in un quadro più ampio di trauma collettivo, prodotto da decenni di occupazione, violenza coloniale e oppressione sistemica. Come sottolineato da Ignacio Martín-Baró, psicologo della liberazione, il trauma non è solo un’esperienza individuale ma si radica nelle strutture di potere che perpetuano disuguaglianze e violenze. A Gaza, la fame non è solo privazione fisica: è un’arma psicologica che mira a minare la coesione sociale, alimentando paura, insicurezza e un senso di impotenza.
A Gaza questa condizione è ulteriormente aggravata dalla memoria della Nakba del 1947-48, un trauma storico che ha segnato l’inizio della pulizia etnica e dell’oppressione sistematica dei palestinesi. L’attuale politica di affamamento è quindi una prosecuzione di una strategia di lungo periodo che mira a frammentare l’identità palestinese. Nei territori occupati, le immagini della crisi a Gaza, amplificate dai social media, rafforzano un senso di isolamento e impotenza tra i palestinesi, che si percepiscono abbandonati dalla comunità internazionale e incapaci di porre fine a questa tragedia.
In questo contesto, Samah Jabr sottolinea il ruolo cruciale dei professionisti della salute mentale in Palestina. Essi non possono limitarsi a trattare i sintomi individuali, ma devono affrontare le radici del trauma, integrando il lavoro terapeutico con interventi pubblici, comunitari e politici. La psicologia della liberazione offre un quadro per comprendere e sfidare le narrazioni che normalizzano la violenza, sostenendo la comunità attraverso spazi sicuri per l’elaborazione collettiva e promuovendo la dignità e la resilienza. Jabr suggerisce un approccio olistico: il sostegno psicosociale deve restituire potere alle persone, aiutandole a riconoscere il legame tra oppressione e vulnerabilità, e a ricostruire un senso di controllo. Inoltre, è indispensabile una mobilitazione internazionale che metta fine all’assedio e all’occupazione. Solo attraverso interventi integrati e solidali si potrà spezzare la spirale di trauma intergenerazionale che colpisce il popolo palestinese e aprire una strada verso la guarigione e la giustizia.
Immagine: fotografia utilizzata da Al Jazeera per illustrare l'articolo di Samah Jabr; raffigura una folla di palestinesi che fanno la fila per ricevere cibo cucinato da una cucina solidale nel nord della Striscia di Gaza, l'11 settembre 2024 [Reuters/Mahmoud Issa].